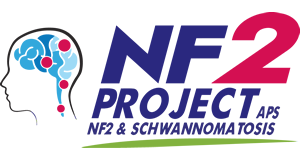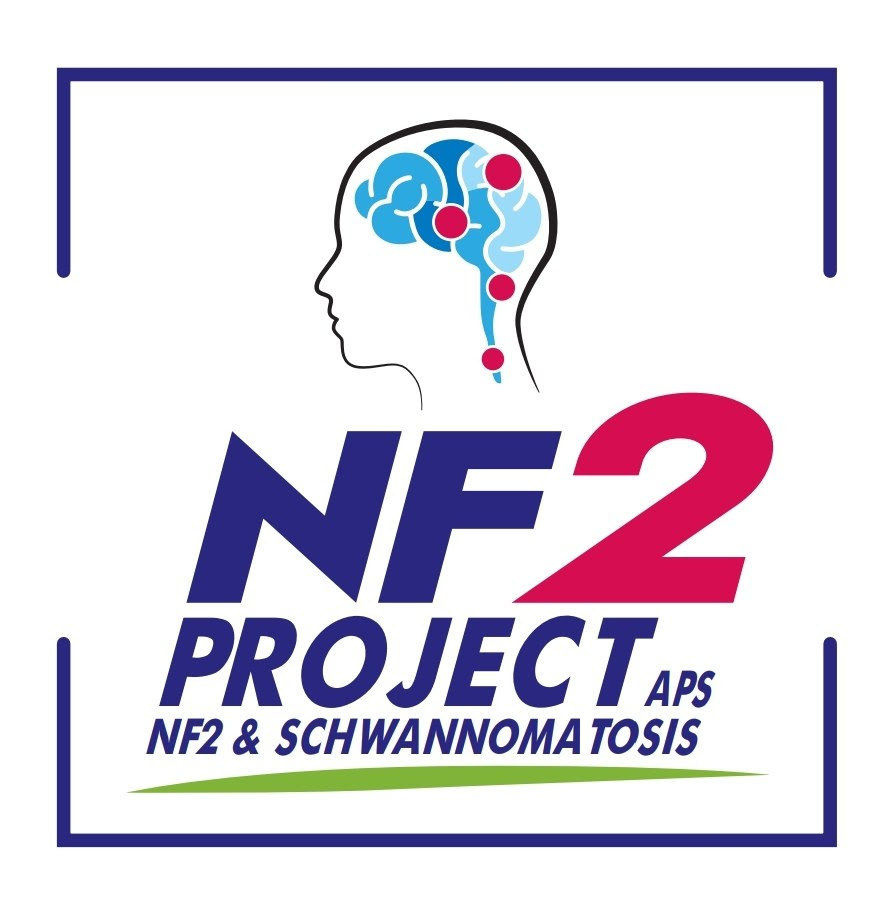CHE COS’E’ LA NF2?
La Neurofibromatosi di tipo 2 (NF2) è una patologia genetica che, a causa di una proteina alterata, predispone allaformazione di tumori benigni sul tessuto nervoso. La proteina, il cui nome è merlina, neurofibromina 2 o schwannomina,è un oncosoppressore, che in condizioni normali lavora per impedire la trasformazione tumorale della cellula, come fosseun poliziotto. Nella NF2, tuttavia, questo poliziotto è stato messo fuori gioco e i tumori possono svilupparsi ovunque nelsistema nervoso, da quello centrale (cervello e midollo spinale) ai nervi periferici.
Le manifestazioni cliniche di questa malattia sono molto variabili, e dipendono dal tipo di mutazione (nonsenso eframeshift sono associate ai casi più critici), dall’età di insorgenza (più in età avanzata si manifesta la malattia, più tendea presentarsi in forma lieve, e viceversa), e quindi dal numero delle lesioni (schwannomi, meningiomi, ependimomi, piùraramente astrocitomi). I tumori NF2 sono generalmente benigni. Il danno che causano deriva dalla compressione cheesercitano sulle strutture nervose, arrivando a pregiudicare la qualità della vita del paziente – perdita dell’udito, disturbivisivi, debolezza facciale, problemi cardiovascolari, dolore neuropatico – e ad essere persino letale nei casi più critici.
Il trattamento per la NF2 è ad oggi essenzialmente chirurgico.
Sono altresì possibili il ricorso alla radiochirurgia o alla terapia farmacologica, e nei prossimi anni dovremmo assistere aun fiorire di opzioni terapeutiche (ne parliamo nel paragrafo conclusivo).
QUALI SONO I SINTOMI NF2?
I sintomi tipici della NF2 derivano dalla formazione degli schwannomi vestibolari (neurinomi acustici), per lo più bilaterali, che pregiudicano la capacità uditiva e di conservare l’equilibrio in posizione eretta e nella deambulazione. In generale, questi sono i sintomi più comuni nella NF2:
- Graduale perdita dell’udito
- Acufeni
- Mancanza di equilibrio
- Paresi facciale
- Debolezza a braccia o gambe
- Dolore
- Disturbi visivi
QUALI SONO I CRITERI DIAGNOSTICI
PER LA NF2?
E’ possibile porre diagnosi di NF2 in presenza di:
- Schwannoma vestibolare bilaterale
- Un familiare di I grado (genitore, fratello, figlio) affetto da NF2 e Schwannoma vestibolare monolaterale insorto prima dei 30 anni di età
Oppure:
- Almeno uno tra i seguenti: meningioma, schwannoma, glioma, neurofibroma, cataratta retro capsulare giovanile
COME SI TRASMETTE E QUALI SONO LE
MUTAZIONI NF2?
Il gene NF2 si trova nel cromosoma 22 e produce una proteina chiamata merlina, isolata per la prima volta nel 1993. Questa proteina riveste una serie di funzioni, la principale delle quali è quella di oncosoppressore.
Che cosa significa?
L’oncosoppressore è come un guardiano che ha il potere di arrestare la progressione del ciclo cellulare, di fronte al presentarsi di mutazioni potenzialmente tumorali per la cellula.
A seguito della mutazione che invalida il gene NF2, quindi, venendo a mancare questo guardiano, l’oncosoppressore, il segnale di proliferazione resterà incontrollato e sempre attivo, portando la cellula tumorale a moltiplicarsi incontrastata. La merlina è un oncosoppressore particolare, che per lo più esercita la sua funzione attraverso l’inibizione da contatto tra le cellule, le quali cessano di crescere quando entrano in contatto tra loro.
Lo Human Gene Mutation Database ha catalogato 345 mutazioni NF2, distribuite come segue: le più frequenti sono le mutazioni nonsenso. Queste sono associate a un quadro clinico più critico, si è detto, specialmente laddove si presentino in età pediatrica.
Seguendo una modalità di trasmissione autosomica dominante, un genitore malato ha circa il 50% di probabilità di generare un figlio malato, a prescindere dall’età del figlio (i dati epidemiologici hanno mostrato che la NF2 può manifestarsi dai 2 anni fino ai 70).
D’altra parte, circa nel 50-60% dei casi si tratta di mutazioni de novo, insorte spontaneamente durante la formazione dell’embrione, costituendo una difficile prova nella diagnosi della malattia.
A ciò si affianca un 30% di casi di mosaicismo, ovvero quando la variante del gene NF2 capace di causare la malattia, insorgendo nelle primissime fasi di sviluppo dell’embrione, come appunto le tessere di un mosaico, non coinvolge tutte le cellule del soggetto, ma solo una popolazione di esse in un singolo individuo, e la severità della malattia dipende dalla percentuale di cellule in cui è avvenuta la mutazione.
In via generale, tuttavia, presentando solo un sottoinsieme cellulare il gene NF2 mutato, tali soggetti tendono ad avere un numero piccolo di tumori, sintomi più modesti, e nel complesso un decorso più lieve.
Il riconoscimento di questa forma di mutazione rappresenta una sfida, poiché i linfociti su cui si esegue l’analisi del DNA, un semplice esame del sangue, possono non presentare l’alterazione, e risulta opportuno procedere alla ricerca della mutazione direttamente attraverso l’indagine del tessuto tumorale del soggetto, qualora ovviamente si presentasse il caso di asportare un tumore.
FATTORI DI RISCHIO
Il principale fattore di rischio per la NF2 è la storia famigliare. Circa nella metà dei casi, la malattia è ereditata, mentre nell’altra metà, la mutazione è spontanea, e avviene al momento del concepimento o nelle prime fasi di sviluppo dell’embrione. Due genitori sani non possono ereditare il gene malato a un figlio. Da un genitore sano e dall’altro malato, le probabilità di avere un figlio sano sono del 50% circa, che scendono al 25% circa se ad essere malati sono entrambi i genitori.
PROTOCOLLO DIAGNOSTICO
- Esame obiettivo
- Visita oculistica
- Audiometria e potenziali acustici evocati
- RM encefalo con mezzo di contrasto
- RM spinale completa con mezzo di contrasto
- Consulenza genetica
PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA
- Valutazione clinica: annuale
- Valutazione oculistica: annuale
- Audiometria e potenziali acustici evocati: annuale
- RM encefalo con mezzo di contrasto: semestrale/annuale
- RM spinale completa con mezzo di contrasto: semestrale/annuale

TERAPIE FARMACOLOGICHE
La strategia terapeutica della NF2 è essenzialmente chirurgica, e talvolta radiochirurgica, ma spesso si adottano entrambe le strade.
In generale l’approccio è quello di monitorare la situazione e intervenire solo nel momento in cui diventa necessario farlo. Vi è però una serie di pazienti che per vari motivi non sono candidabili al trattamento chirurgico, e soprattutto per loro nasce l’urgenza di individuare possibili target farmacologici, che possano interferire mitigando o arrestando la progressione delle lesioni tumorali.
Ad oggi non sono disponibili agenti chemioterapici per questi tumori, e l’approccio di prima scelta resta la chirurgia, anche se farmaci come Everolimus (inibisce un segnale di crescita cellulare) e soprattutto bevacizumab (contrasta la formazione di nuovi vasi sanguigni che nutrono il tumore, affamandolo) vengono adottati con alterni risultati.
Mentre è stata dimostrata l’efficacia del bevacizumab nel migliorare l’udito di diversi pazienti con NF2, riducendo il volume degli schwannomi vestibolari, è ancora controverso l’effetto del bevacizumab sui meningiomi.
In generale, tuttavia, questo farmaco appare ben tollerato, ed efficace nel rallentare la crescita in particolare dei neurinomi acustici.
In conclusione va specificato che con il tempo, benché in terapia, la funzionalità dei nervi acustici va diminuendo. Soprattutto, è bene chiarire che non è possibile, come per ogni altro farmaco, ricondurre i possibili effetti collaterali a ciascun paziente.
Nei prossimi anni, già prima del 2030, sono attesi nuovi farmaci, attualmente in fase di sperimentazione, che promettono di essere una preziosa risorsa per i malati di NF2.
Come associazione, NF2 Project seguirà gli sviluppi della ricerca e aggiornerà puntualmente gli utenti del sito e gli iscritti.